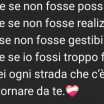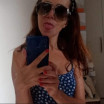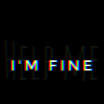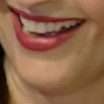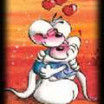I SETTE VIZI CAPITALI 4. L'ACCIDIA
-
02/01/2008 | RosannaP.
- 5100
(segue l'intervento del 31/12/2007)
[img src=/data/rubriche/58ryyo4z7x6wraomkhsa1199300624.jpg alt=Immagine>
Storicamente l'ozio indicava una vita votata alla contemplazione intellettuale, alla speculazione filosofica, un lusso che si potevano permettere, ovviamente, soltanto le classi dominanti e quelle aristocratiche. Oziare, il “dolce far niente” ha assunto poi un significato con valenza negativa, diventando così il padre di tutti i vizi. Successivamente è diventato sinonimo di inattività, pigrizia ed inerzia,anche se non è sempre stato oggetto di riprovazione sociale.
Oggi vengono considerati due tipi di ozio, uno benefico, cioè una forma di attività riempita di significato, come la lettura, lo sport,gli hobby,ecc, ed un ozio affaticato, cioè l'inattività pura, che appunto, lascia completamente a riposo la mente. E' l'inattività, quindi il tipo di ozio inteso come un momento piatto, senza obiettivo e fine a se stesso, un momento fermo, alla base dell'accidia, cioè il peccato che descrive la noia e l'indifferenza. Si dice che gli dei erano accidiosi e si annoiavano, così fu creato l'uomo.
Adamo, Eva, Caino, Abele e il popolo sono tutti considerati degli accidiosi, poiché dall'annoiarsi dell'uno, è derivata la noia del secondo, e così in avanti, tanto da coinvolgere tutti. Quando la popolazione aumentò, la gente iniziò a formare la massa , anch'essa annoiata a considerata stupida in quanto tale.
I simboli che rappresentano l'accidia sono normalmente un uomo addormentato, che quindi non pecca, ma neppure pratica la fede,o esegue lavori senza portarli a termine.
Moralmente l'accidia viene pienamente bocciata, perché indica scoraggiamento,abbattimento e stanchezza, tra l'altro sentimenti del tutto ingiustificati se si pensa al fatto che nulla è la causa di tali malesseri, se non una predisposizione dell'animo. Poiché l'accidia genera tristezza, anche da un punto di vista psicodinamico è importante notare come esso sia alla base di importanti patologie, tra le quali spicca la depressione ( o melanconia), chiamata “il male di vivere” non a caso. Secondo una prospettiva sociologica, invece, l'accidioso sarebbe un attore deviante che mette in pericolo l'ordine sociale, poiché con la sua inattività, non produce né in termini economico-materiali, né in termini di valori (morali, educativi, ...), ma che allo stesso tempo consuma il lavoro di altri.
[img src=/data/rubriche/rwsyxvwni0pqosg5io411199300661.jpg alt=Immagine>
Dante, che nel Convivio sembra considerarla un "vizio per difetto dell'ira", nel VII canto della Divina Commedia pone gli accidiosi nella palude Stigia, insieme agli iracondi; nel Purgatorio, invece, li colloca nel IV girone, puniti attraverso un' eterna corsa frettolosa per la cornice, gridando esempi di sollecitudine e di accidia punita.
L'accidia è una situazione vitale (che a questo punto è anche troppo definirla così) priva di passione.
Da essa deriva la presunzione da parte dell'accidioso che tutti gli debbano qualcosa, che esso sia un incompreso, che meriterebbe di più dalla vita e dagli altri, che siano le situazioni a negargli quanto egli, in teoria, vorrebbe ottenere (perché nella pratica l'impegno e il sacrificio per ottenere qualcosa è nullo), che infine degenera sia verso una condizione deprimente per se stesso e per gli altri intorno a lui, sia verso una condizione di eterna mancanza, sia materiale che spirituale ed intellettiva. L'accidia deriva, secondo Dante, dall'ira, cioè dal sentimento di rabbia, dalla sovrabbondanza di emozione non finalizzata a nulla, ma canalizzata verso l'esterno e quindi dispersa perché non trova riscontro né in motivazioni, né in obiettivi veramente esistenti.
Quindi accidia è il termine usato per descrivere la condizione psicofisica dell'irato, causata da una aggravatio animi così profonda e duratura da immobilizzare o paralizzare anche le membra esterne, impedire l'apparato fono-articolatorio e quindi troncare la parola stessa. In pratica, l'ira è un fuoco che si nutre di paglia, si accende facilmente e brucia in fretta; la stessa fretta ci mette a spegnersi e poi a riaccendersi, producendo si un calore (metaforicamente mi riferisco al “sangue caldo” tipico di alcune persone), ma un calore fondamentalmente debole e provvisorio, più vicino al tiepido, di conseguenza vano: è qui che l'ira si trasforma ed è la base dell'essere accidioso. La rabbia e l'intensità delle emozioni sono ben altra cosa, e non decadono affatto nel peccato, ma al contrario, sono alla base di una vitalità e di una volontà che caratterizzano le persone vive fisicamente e moralmente.
La morale cristiana naturalmente non può giustificare tale modo d'essere (definitivo) o lo stato d'animo a cui si riferisce (provvisorio, perciò), perché è un vizio capitale costituito dall'indolenza nell'operare il bene. Chi pecca di accidia, per la cristianità, non prova dolore, è incurante, negligente, pigro. Il non provare dolore non è peccato di per sé, ma indica in questo caso la mancanza di qualunque forma di empatia, alla base dei rapporti tra le persone, che si dovrebbero relazionare sulla base della fraternità, della solidarietà, del sentire allo stesso modo. E' ovvio, perciò, che colui il quale non cerca di essere un minimo empatico, cioè non si mette mai nei panni degli altri, non può capire le persone e le situazioni, quindi le sue considerazioni e i suoi comportamenti saranno sempre il risultato dell'incomprensione volutamente data, ovvero della vera e assoluta ignoranza. L'accidioso, non da ultimo, è un egoista. L'accidia è secondo Jabès il “luogo privilegiato della spersonalizzazione”, infatti era abitudine dei monaci medioevali andare nei luoghi deserti per ritrovare se stessi e Dio, ma, invece di raggiungere questo scopo, finivano
coll' imbattersi nell'accidia.
Per esempio, Seneca trattando dell'ozio in relazione alla serenità dell'animo, non rimprovera affatto chi impegna la propria esistenza dedicandola alle attività intellettuali: anzi, preferisce che ognuno segua la propria strada, compresa la passione per la filosofia, la storia, le lettere e così via, purchè diano come frutti un animo moralmente alto ed evoluto, predisposto a fare il bene. Egli suggerisce inoltre, in linea con i massimi pensatori di ogni tempo, che il vero filosofo alla fine, giunga ad occuparsi attivamente di politica, quindi di andare oltre le teorizzazioni, le relazioni dialettiche che descrivono il mondo, oltre l'idealismo di una giusta politica, di una giusta educazione, di una vera ed utile morale, ma applicare direttamente questi saperi, proprio perché sono tutti coloro che detengono, effettivamente, la conoscenza. Seneca non trova, però, un obbligo morale nella politica, ma lascia aperta la strada che il filosofo preferisce percorrere, pur cosciente che mai deve cadere nella pura inattività, sconsacrando così il significato della sua esistenza.
Ovviamente questi ultimi due sono esempi del tutto contrapposti nelle modalità attraverso le quali prende forma l'ozio, il primo dei quali è riferito al circolo vizioso che produce accidia. Entrambi però servono a riflettere sulla linea sottile che separa i tipi di vivere oziando.
Gli accidiosi, questi sciagurati, che mai non fur vivi (Inf. III, 64) non meritano giustificazione, e ancor peggio, essi stessi non si rendono conto che dovrebbero provar compassione per se stessi, anziché cullarsi compiacenti. Chi li aiuta a rimanere in basso, pur in buona fede, magari facendo per conto loro lavori di varia natura, inoltre, pecca con loro. Basta pensare al disinteresse di tutti coloro i quali non sono in grado di rendersi indipendenti ad un certo punto della loro vita, non solo economicamente parlando (che certamente oggi è qualcosa di più difficile ottenere ), ma generalmente in tutte le cose, dal mettere in ordine e pulire se stessi, gli ambienti nei quali vivono, rispettando le persone che abitano gli stessi spazi con loro, abituati ad essere serviti ed essere irresponsabili. Quanti ragazzi della mia età - e mi riferisco anche alle ragazze, ovvio- non sono capaci neanche di mettere un uovo in pentola per mangiarlo, se non c'è la mamma che mette loro il piatto pronto a tavola? La colpa non è soltanto di chi si fa servire, ma anche e soprattutto chi li ha educati ad essere sempre passivi in tutto (causa, a mio avviso, dell'altissimo tasso di divorzi...).
Ne deriva, quindi, che l'accidia è anche omologazione, automatismo: tutti sono alla ricerca dell'originalità, e credono di trovarla nella borsetta o nel cappellino di Louis Vuitton (tra l'altro in mano a chiunque, giusto per chi non lo avesse ancora notato), ovviamente perché è più facile comprare una certa “personalità” (intesa come qualità notoriamente attribuita a vini, profumi, quindi come prodotto di un marketing) che cercarne una propria (non in negozio chiaramente!!!!). Prima parlavo di egoismo, proprio perché, anche in virtù di questo processo di omologazione, l'accidia non è altro che autodirezione. E' un atteggiamento alla base di processi masturbatori, basati su fantasticherie, che purtroppo, portano alla distruzione dei rapporti con gli altri, all'incapacità di mettersi in relazione con oggetti fuori dal proprio Sé, di considerare la vera natura del mondo e delle cose, fino a giungere ad una chiusura totalizzante in se stessi, fonte di angoscia e crisi d'ansia, primi sintomi della depressione.
Assomiglia alla depressione perché toglie ogni erotizzazione ai gesti della vita.
L'accidia porta a rendere pesante di ogni cosa: voglia di scappare o evitare le situazioni, continuo sonno e bisogno di dormire. Un mondo senza particolari emozioni rende incapaci di partecipare alla vita, al lavoro, agli studi, alla famiglia, agli amici, e tutto assume un senso perduto. L'aver perduto la possibilità di offrire la propria vitalità, il proprio entusiasmo, la propria energia si riscontra soprattutto nella mancanza di obiettivi, sogni, passioni e momenti condivisibili. Perciò diventa un sentire di essere stati estromessi dal mondo, un veder sempre prevalere lo stesso spettacolo, gli stessi copioni, le stesse regole.
L'accidia è la base dell'alienazione, perché è un modo di vivere sia individualmente che collettivamente "in automatico", caratterizzato da una pacifica e riposante omologazione.
Gli psichiatri definiscono questa situazione “neuroastenia”,che come suggerisce la parola stessa, è un “astenersi da”, è un'anoressia che si manifesta sotto la forma nervosa. E' il risultato fisiopatologico dello stess risultante dall'inattività, quindi naturale e progressivo susseguirsi dello stare sempre fermi, immobili, e che riduce il cervello a ripiegare su se stesso perché non ha nuovi stimoli da elaborare, e produce una sorta di eco che rimbomba nella mente e fa diventare i pensieri vere e proprie ossessioni, manie di persecuzioni e paranoie.
Pensiamo ad esempio ai casi delle persone che si trovano a stare fermi per un certo periodo di tempo a letto (purtroppo) per vari motivi, o anche soltanto a quel che succede ad un braccio che viene ingessato dopo che si spezza: esso dimagrisce, si affloscia, perde colore, forma, sostanza, utilità e deve essere riabilitato, altrimenti diventa man mano sempre più morto, dolente, brutto anche solo da guardare.
Si può individuare tranquillamente senza che si arrivi alla degenerazione, perciò questo processo non va considerato come un'anormalità in quanto tale, tutt'altro. Si manifesta attraverso la tachicardia, l'ipertensione, la gastrite, la nausea, disturbi della sfera sessuale,l' insonnia, varie forme di devianza, abuso di farmaci e psicofarmaci, tossicomania,fino a scontrarsi con la psicosi vera e propria.
E' importante ritrovare perciò un equilibrio e una stabilità concreta, cioè piena di significato vitale, trovandosi un ruolo nella società, in famiglia, escogitando modi per esprimere se stessi, non soltando nel lavoro o nello studio, ma attraverso altri processi che mettano in moto per esempio la propria creatività in maniera costruttiva ed obiettiva. E' chiaro che ritagliarsi una posizione che non è la propria (nella vita di relazione, intendo) produce gli stessi effetti dell'inattività. Detto in poche parole, è importante fare qualcosa nella vita, ma un qualcosa di veramente concreto, perché la fantasticheria e l'immobilità esistenziale producono un male per se stessi e per gli altri, non soltanto da un punto di vista etico.
[img src=/data/rubriche/whjaliu2t9q89tt0oiqr1199300692.jpg alt=Immagine>
“Il vero dramma del nostro tempo è l'indifferenza, il tedio, la torva abulìa, l'Accidia di coloro che vivon senza infamia e senza lode, anzi che mai non sono vivi o si insteriliscono come un albero che non produce né germogli, né foglie, né frutti. È tralcio improduttivo e bastardo. Non si protende alto nel cielo azzurro, ma - sradicato - si staglia in una atmosfera ingrigita. In primo piano due donne. L'una, seduta e di schiena, potrebbe ricordare la splendida Bagneuse di Ingres se non fosse così rassegnatamente abbandonata e con il capo reclinato, quasi costretto a rivolgersi in basso dalla pesante capiglitura ricadente sul petto in due folte e scure ciocche che si dipartono dalla scriminatura.
La donna distesa è tanto ugualmente infiacchita dalla pigrizia che potrebbe essere la stessa persona raffigurata in altra posa. Il levigato splendore del suo corpo, la bellezza del suo viso, la morbida lucentezza dei suoi lunghi e folti capelli, la rendono ancora più colpevole. È pavida e rinunciataria. Non crede a nulla, non desidera nulla, non vuole fare nulla, né il bene e nemmeno il male, così macchiandosi del Male peggiore, quello della nostra "società frigida", incolore, insapore, indifferente.
E' il l senso di una desolazione in cui tutto è tristissima inerzia e nulla appare desiderabile.”
(Mario Donizetti, I vizi capitali, 1999)
E', perciò, giustificabile chi, avendo abusato di piacere derivante dalla propria condizione (sia del ragazzo viziato, appunto, sia della donna bella nel dipinto di Donizetti che non si cura d'altro )
si trova nell' “ impossibilità “ di desiderare altro?
Io penso di no. Preferire lo star fermi nella vita è un vizio, e ammala corpo e anima. C'è sempre chi si sente sazio solo a guardarsi allo specchio, e c'è chi poi, non lo fa per niente. Sono condizioni umane che scaturiscono dal dono del libero arbitrio, di cui molti non sanno cosa farsene o peggio, lo confondono con altro ancora, ma certo non sono determinate dalla “sfortuna” o da cause terze. E' fisiologica anche la conclusione del mio ragionamento: ancora una volta è la volontà dell'uomo a determinare i suoi mali.
Rosanna Perrone
[img src=/data/rubriche/58ryyo4z7x6wraomkhsa1199300624.jpg alt=Immagine>
Storicamente l'ozio indicava una vita votata alla contemplazione intellettuale, alla speculazione filosofica, un lusso che si potevano permettere, ovviamente, soltanto le classi dominanti e quelle aristocratiche. Oziare, il “dolce far niente” ha assunto poi un significato con valenza negativa, diventando così il padre di tutti i vizi. Successivamente è diventato sinonimo di inattività, pigrizia ed inerzia,anche se non è sempre stato oggetto di riprovazione sociale.
Oggi vengono considerati due tipi di ozio, uno benefico, cioè una forma di attività riempita di significato, come la lettura, lo sport,gli hobby,ecc, ed un ozio affaticato, cioè l'inattività pura, che appunto, lascia completamente a riposo la mente. E' l'inattività, quindi il tipo di ozio inteso come un momento piatto, senza obiettivo e fine a se stesso, un momento fermo, alla base dell'accidia, cioè il peccato che descrive la noia e l'indifferenza. Si dice che gli dei erano accidiosi e si annoiavano, così fu creato l'uomo.
Adamo, Eva, Caino, Abele e il popolo sono tutti considerati degli accidiosi, poiché dall'annoiarsi dell'uno, è derivata la noia del secondo, e così in avanti, tanto da coinvolgere tutti. Quando la popolazione aumentò, la gente iniziò a formare la massa , anch'essa annoiata a considerata stupida in quanto tale.
I simboli che rappresentano l'accidia sono normalmente un uomo addormentato, che quindi non pecca, ma neppure pratica la fede,o esegue lavori senza portarli a termine.
Moralmente l'accidia viene pienamente bocciata, perché indica scoraggiamento,abbattimento e stanchezza, tra l'altro sentimenti del tutto ingiustificati se si pensa al fatto che nulla è la causa di tali malesseri, se non una predisposizione dell'animo. Poiché l'accidia genera tristezza, anche da un punto di vista psicodinamico è importante notare come esso sia alla base di importanti patologie, tra le quali spicca la depressione ( o melanconia), chiamata “il male di vivere” non a caso. Secondo una prospettiva sociologica, invece, l'accidioso sarebbe un attore deviante che mette in pericolo l'ordine sociale, poiché con la sua inattività, non produce né in termini economico-materiali, né in termini di valori (morali, educativi, ...), ma che allo stesso tempo consuma il lavoro di altri.
[img src=/data/rubriche/rwsyxvwni0pqosg5io411199300661.jpg alt=Immagine>
Dante, che nel Convivio sembra considerarla un "vizio per difetto dell'ira", nel VII canto della Divina Commedia pone gli accidiosi nella palude Stigia, insieme agli iracondi; nel Purgatorio, invece, li colloca nel IV girone, puniti attraverso un' eterna corsa frettolosa per la cornice, gridando esempi di sollecitudine e di accidia punita.
L'accidia è una situazione vitale (che a questo punto è anche troppo definirla così) priva di passione.
Da essa deriva la presunzione da parte dell'accidioso che tutti gli debbano qualcosa, che esso sia un incompreso, che meriterebbe di più dalla vita e dagli altri, che siano le situazioni a negargli quanto egli, in teoria, vorrebbe ottenere (perché nella pratica l'impegno e il sacrificio per ottenere qualcosa è nullo), che infine degenera sia verso una condizione deprimente per se stesso e per gli altri intorno a lui, sia verso una condizione di eterna mancanza, sia materiale che spirituale ed intellettiva. L'accidia deriva, secondo Dante, dall'ira, cioè dal sentimento di rabbia, dalla sovrabbondanza di emozione non finalizzata a nulla, ma canalizzata verso l'esterno e quindi dispersa perché non trova riscontro né in motivazioni, né in obiettivi veramente esistenti.
Quindi accidia è il termine usato per descrivere la condizione psicofisica dell'irato, causata da una aggravatio animi così profonda e duratura da immobilizzare o paralizzare anche le membra esterne, impedire l'apparato fono-articolatorio e quindi troncare la parola stessa. In pratica, l'ira è un fuoco che si nutre di paglia, si accende facilmente e brucia in fretta; la stessa fretta ci mette a spegnersi e poi a riaccendersi, producendo si un calore (metaforicamente mi riferisco al “sangue caldo” tipico di alcune persone), ma un calore fondamentalmente debole e provvisorio, più vicino al tiepido, di conseguenza vano: è qui che l'ira si trasforma ed è la base dell'essere accidioso. La rabbia e l'intensità delle emozioni sono ben altra cosa, e non decadono affatto nel peccato, ma al contrario, sono alla base di una vitalità e di una volontà che caratterizzano le persone vive fisicamente e moralmente.
La morale cristiana naturalmente non può giustificare tale modo d'essere (definitivo) o lo stato d'animo a cui si riferisce (provvisorio, perciò), perché è un vizio capitale costituito dall'indolenza nell'operare il bene. Chi pecca di accidia, per la cristianità, non prova dolore, è incurante, negligente, pigro. Il non provare dolore non è peccato di per sé, ma indica in questo caso la mancanza di qualunque forma di empatia, alla base dei rapporti tra le persone, che si dovrebbero relazionare sulla base della fraternità, della solidarietà, del sentire allo stesso modo. E' ovvio, perciò, che colui il quale non cerca di essere un minimo empatico, cioè non si mette mai nei panni degli altri, non può capire le persone e le situazioni, quindi le sue considerazioni e i suoi comportamenti saranno sempre il risultato dell'incomprensione volutamente data, ovvero della vera e assoluta ignoranza. L'accidioso, non da ultimo, è un egoista. L'accidia è secondo Jabès il “luogo privilegiato della spersonalizzazione”, infatti era abitudine dei monaci medioevali andare nei luoghi deserti per ritrovare se stessi e Dio, ma, invece di raggiungere questo scopo, finivano
coll' imbattersi nell'accidia.
Per esempio, Seneca trattando dell'ozio in relazione alla serenità dell'animo, non rimprovera affatto chi impegna la propria esistenza dedicandola alle attività intellettuali: anzi, preferisce che ognuno segua la propria strada, compresa la passione per la filosofia, la storia, le lettere e così via, purchè diano come frutti un animo moralmente alto ed evoluto, predisposto a fare il bene. Egli suggerisce inoltre, in linea con i massimi pensatori di ogni tempo, che il vero filosofo alla fine, giunga ad occuparsi attivamente di politica, quindi di andare oltre le teorizzazioni, le relazioni dialettiche che descrivono il mondo, oltre l'idealismo di una giusta politica, di una giusta educazione, di una vera ed utile morale, ma applicare direttamente questi saperi, proprio perché sono tutti coloro che detengono, effettivamente, la conoscenza. Seneca non trova, però, un obbligo morale nella politica, ma lascia aperta la strada che il filosofo preferisce percorrere, pur cosciente che mai deve cadere nella pura inattività, sconsacrando così il significato della sua esistenza.
Ovviamente questi ultimi due sono esempi del tutto contrapposti nelle modalità attraverso le quali prende forma l'ozio, il primo dei quali è riferito al circolo vizioso che produce accidia. Entrambi però servono a riflettere sulla linea sottile che separa i tipi di vivere oziando.
Gli accidiosi, questi sciagurati, che mai non fur vivi (Inf. III, 64) non meritano giustificazione, e ancor peggio, essi stessi non si rendono conto che dovrebbero provar compassione per se stessi, anziché cullarsi compiacenti. Chi li aiuta a rimanere in basso, pur in buona fede, magari facendo per conto loro lavori di varia natura, inoltre, pecca con loro. Basta pensare al disinteresse di tutti coloro i quali non sono in grado di rendersi indipendenti ad un certo punto della loro vita, non solo economicamente parlando (che certamente oggi è qualcosa di più difficile ottenere ), ma generalmente in tutte le cose, dal mettere in ordine e pulire se stessi, gli ambienti nei quali vivono, rispettando le persone che abitano gli stessi spazi con loro, abituati ad essere serviti ed essere irresponsabili. Quanti ragazzi della mia età - e mi riferisco anche alle ragazze, ovvio- non sono capaci neanche di mettere un uovo in pentola per mangiarlo, se non c'è la mamma che mette loro il piatto pronto a tavola? La colpa non è soltanto di chi si fa servire, ma anche e soprattutto chi li ha educati ad essere sempre passivi in tutto (causa, a mio avviso, dell'altissimo tasso di divorzi...).
Ne deriva, quindi, che l'accidia è anche omologazione, automatismo: tutti sono alla ricerca dell'originalità, e credono di trovarla nella borsetta o nel cappellino di Louis Vuitton (tra l'altro in mano a chiunque, giusto per chi non lo avesse ancora notato), ovviamente perché è più facile comprare una certa “personalità” (intesa come qualità notoriamente attribuita a vini, profumi, quindi come prodotto di un marketing) che cercarne una propria (non in negozio chiaramente!!!!). Prima parlavo di egoismo, proprio perché, anche in virtù di questo processo di omologazione, l'accidia non è altro che autodirezione. E' un atteggiamento alla base di processi masturbatori, basati su fantasticherie, che purtroppo, portano alla distruzione dei rapporti con gli altri, all'incapacità di mettersi in relazione con oggetti fuori dal proprio Sé, di considerare la vera natura del mondo e delle cose, fino a giungere ad una chiusura totalizzante in se stessi, fonte di angoscia e crisi d'ansia, primi sintomi della depressione.
Assomiglia alla depressione perché toglie ogni erotizzazione ai gesti della vita.
L'accidia porta a rendere pesante di ogni cosa: voglia di scappare o evitare le situazioni, continuo sonno e bisogno di dormire. Un mondo senza particolari emozioni rende incapaci di partecipare alla vita, al lavoro, agli studi, alla famiglia, agli amici, e tutto assume un senso perduto. L'aver perduto la possibilità di offrire la propria vitalità, il proprio entusiasmo, la propria energia si riscontra soprattutto nella mancanza di obiettivi, sogni, passioni e momenti condivisibili. Perciò diventa un sentire di essere stati estromessi dal mondo, un veder sempre prevalere lo stesso spettacolo, gli stessi copioni, le stesse regole.
L'accidia è la base dell'alienazione, perché è un modo di vivere sia individualmente che collettivamente "in automatico", caratterizzato da una pacifica e riposante omologazione.
Gli psichiatri definiscono questa situazione “neuroastenia”,che come suggerisce la parola stessa, è un “astenersi da”, è un'anoressia che si manifesta sotto la forma nervosa. E' il risultato fisiopatologico dello stess risultante dall'inattività, quindi naturale e progressivo susseguirsi dello stare sempre fermi, immobili, e che riduce il cervello a ripiegare su se stesso perché non ha nuovi stimoli da elaborare, e produce una sorta di eco che rimbomba nella mente e fa diventare i pensieri vere e proprie ossessioni, manie di persecuzioni e paranoie.
Pensiamo ad esempio ai casi delle persone che si trovano a stare fermi per un certo periodo di tempo a letto (purtroppo) per vari motivi, o anche soltanto a quel che succede ad un braccio che viene ingessato dopo che si spezza: esso dimagrisce, si affloscia, perde colore, forma, sostanza, utilità e deve essere riabilitato, altrimenti diventa man mano sempre più morto, dolente, brutto anche solo da guardare.
Si può individuare tranquillamente senza che si arrivi alla degenerazione, perciò questo processo non va considerato come un'anormalità in quanto tale, tutt'altro. Si manifesta attraverso la tachicardia, l'ipertensione, la gastrite, la nausea, disturbi della sfera sessuale,l' insonnia, varie forme di devianza, abuso di farmaci e psicofarmaci, tossicomania,fino a scontrarsi con la psicosi vera e propria.
E' importante ritrovare perciò un equilibrio e una stabilità concreta, cioè piena di significato vitale, trovandosi un ruolo nella società, in famiglia, escogitando modi per esprimere se stessi, non soltando nel lavoro o nello studio, ma attraverso altri processi che mettano in moto per esempio la propria creatività in maniera costruttiva ed obiettiva. E' chiaro che ritagliarsi una posizione che non è la propria (nella vita di relazione, intendo) produce gli stessi effetti dell'inattività. Detto in poche parole, è importante fare qualcosa nella vita, ma un qualcosa di veramente concreto, perché la fantasticheria e l'immobilità esistenziale producono un male per se stessi e per gli altri, non soltanto da un punto di vista etico.
[img src=/data/rubriche/whjaliu2t9q89tt0oiqr1199300692.jpg alt=Immagine>
“Il vero dramma del nostro tempo è l'indifferenza, il tedio, la torva abulìa, l'Accidia di coloro che vivon senza infamia e senza lode, anzi che mai non sono vivi o si insteriliscono come un albero che non produce né germogli, né foglie, né frutti. È tralcio improduttivo e bastardo. Non si protende alto nel cielo azzurro, ma - sradicato - si staglia in una atmosfera ingrigita. In primo piano due donne. L'una, seduta e di schiena, potrebbe ricordare la splendida Bagneuse di Ingres se non fosse così rassegnatamente abbandonata e con il capo reclinato, quasi costretto a rivolgersi in basso dalla pesante capiglitura ricadente sul petto in due folte e scure ciocche che si dipartono dalla scriminatura.
La donna distesa è tanto ugualmente infiacchita dalla pigrizia che potrebbe essere la stessa persona raffigurata in altra posa. Il levigato splendore del suo corpo, la bellezza del suo viso, la morbida lucentezza dei suoi lunghi e folti capelli, la rendono ancora più colpevole. È pavida e rinunciataria. Non crede a nulla, non desidera nulla, non vuole fare nulla, né il bene e nemmeno il male, così macchiandosi del Male peggiore, quello della nostra "società frigida", incolore, insapore, indifferente.
E' il l senso di una desolazione in cui tutto è tristissima inerzia e nulla appare desiderabile.”
(Mario Donizetti, I vizi capitali, 1999)
E', perciò, giustificabile chi, avendo abusato di piacere derivante dalla propria condizione (sia del ragazzo viziato, appunto, sia della donna bella nel dipinto di Donizetti che non si cura d'altro )
si trova nell' “ impossibilità “ di desiderare altro?
Io penso di no. Preferire lo star fermi nella vita è un vizio, e ammala corpo e anima. C'è sempre chi si sente sazio solo a guardarsi allo specchio, e c'è chi poi, non lo fa per niente. Sono condizioni umane che scaturiscono dal dono del libero arbitrio, di cui molti non sanno cosa farsene o peggio, lo confondono con altro ancora, ma certo non sono determinate dalla “sfortuna” o da cause terze. E' fisiologica anche la conclusione del mio ragionamento: ancora una volta è la volontà dell'uomo a determinare i suoi mali.
Rosanna Perrone
Articoli correlati
Circus beatclub Brescia a Pasqua '25 come ad Ibiza: 5 notti di party, con Samuele Sartini (remixer per Cremonini) ed il DJ londi
14/04/2025 | lorenzotiezzi
e' una settimana intensa quella che mette in scena circus beatclub, il top club di brescia che ogni weekend (e non solo) fa scatenare con party e dj...
PasquaMarittima @ Papeete Beach - Milano Marittima dal 19 al 21 aprile: l'estate 2025 inizia con Nicola Zucchi, Samuele Sartini
14/04/2025 | lorenzotiezzi
una spiaggia d'eccellenza in cui rilassarsi tutto il giorno e grandi dj ogni pomeriggio; servizi a cinque stelle per chi lo desidera e ingresso libero pe...
Ben Dj e la sua cover di "Azzurro" bloccata da Claudia Mori. “Perché?”
10/04/2025 | lorenzotiezzi
ben dj aveva realizzato una scatenata cover di "azzurro", il capolavoro scritto da paolo conte (musiche) e vito pallavicini (testo) per adriano celentano. ...